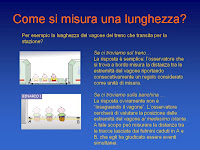La descrizione del cosmo nel mondo anticoFin dalla Preistoria l'uomo é stato colpito dalla regolarità dei moti apparenti delle stelle, del Sole, della Luna e li ha studiati, anche al fine di misurare il tempo. II moto dei corpi celesti appariva inoltre il segno di un ordine della natura di origine divina; infatti, quella che oggi chiamiamo astronomia era collegata un tempo a significati religiosi e magici. Osservazioni accurate erano state compiute anche al fine di predire fenomeni, come le eclissi di Sole, a cui si attribuivano significati catastrofici. In ciò furono maestri i popoli mesopotamici e assiro-babilonesi, ma non ci sono evidenze che essi andassero al di là di una pura descrizione dei moti apparenti, senza la ricerca di quello che oggi chiameremmo un modello. La visione cosmologica prevalente di quell'epoca era quella di una Terra piatta e interamente circondata da acque, racchiusa in una specie di guscio di cui il cielo rappresentava la parte superiore.
Il moto retrogrado dei pianeti
Una prima svolta nella ricerca di un ordine razionale dell'Universo va attribuita ai pitagorici, convinti assertori di una filosofia secondo la quale i numeri e le relazioni matematiche e geometriche costituiscono l'essenza di tutte le cose. Secondo questi filosofi, il simbolo della perfezione é la sfera, e quindi la Terra doveva essere sferica e i corpi celesti, corpi perfetti dell'Universo, dovevano essere sferici e dovevano muoversi su sfere, con moto circolare uniforme eterno e immutabile. Questo primo modello era coerente con l'osservazione delle stelle, che sembrano compiere un moto regolare di periodo pari a un giorno, ruotando tutte insieme intorno a un asse che passa approssimativamente per la stella polare.
Tuttavia, esistono alcuni corpi celesti (il Sole, la Luna e i pianeti) che hanno un periodo di rotazione piú lungo di quello delle stelle e che quindi compiono un lento spostamento verso est rispetto a esse. Questo fatto venne interpretato comunque in termini di moto circolare intorno alla Terra, supponendo che questi corpi il Sole e la Luna in particolare - fossero dotati di due moti circolari sovrapposti:
uno solidale a quello delle stelle fisse e l'altro, di periodo caratteristico per ciascuno di essi, che li faceva ruotare lentamente in senso opposto a quello.
Tuttavia i pianeti apparivano animati da uno strano movimento ben difficilmente riconducibile a un moto circolare, avente come centro la Terra.
Proprio questa anomalia del loro movimento determinò la loro denominazione; il termine pianeta deriva, infatti, da una parola greca che significa "errante". Essi infatti, pur mostrando lo spostamento verso est, come il Sole e la Luna, in certi periodi dell'anno invertono il loro moto rispetto alle stelle, retrocedendo verso ovest, per poi ritornare a muoversi verso est. Nel complesso essi eseguono un
moto ad anello detto moto retrogrado.
Anche questa anomalia venne però superata da modelli cosmologici nei quali venivano composti tra loro piú movimenti sempre circolari. II modello di questo tipo che meglio descriveva i fenomeni celesti allora noti é opera di Claudio Tolomeo (figura 25), astronomo del II secolo d. C. Unica eccezione alle cosmologie geocentriche é l'ipotesi dell'astronomo greco Aristarco di Samo che, nel III secolo a.C., propose un modello in cui il Sole è fermo al centro dell'Universo mentre la Terra e i pianeti ruotano intorno a esso. L'ipotesi di Aristarco rimase peró isolata nel mondo antico perché contro ad essa potevano essere mosse obiezioni piuttosto forti. Un primo tipo di obiezioni era riconducibile all'ignoranza del principio di composizione dei movimenti. Un secondo tipo era associato al fatto che se la Terra si muove rispetto alle stelle, che si immaginano fisse, dovremmo osservare, durante l'anno, uno spostamento della posizione angolare delle stelle, dal momento che varia la prospettiva dalla quale vengono osservate. Per spiegare l'assenza di questo spostamento angolare era necessario ammettere che lo spostamento della Terra, corrispondente a un diametro dell'orbita intorno al Sole, fosse cosí piccolo rispetto alle distanze stellari da essere trascurabile ai fini di una variazione di prospettiva. Ne conseguiva un ampliamento enorme delle dimensioni dell'Universo: le stelle dovevano essere almeno migliaia di volte piú lontane del Sole rispetto alla Terra. Ma nella visione del mondo degli antichi questa ipotesi appariva assurda e il modello di Aristarco rimase perciò una semplice curiosità, fino a quando Copernico non seppe utilizzarlo per un ribaltamento della visione cosmologica.
Lo rivoluzione copernicanaII 24 maggio 1543 venne pubblicato il De revolutionibus orbium coelestium, l'opera di Copernico destinata a sconvolgere la visione cosmologica degli antichi. In quest'opera Copernico riprende l'ipotesi eliocentrica di Aristarco, arricchendola di nuove osservazioni e calcoli e sostenendo che i complicati moti retrogradi dei pianeti spariscono se immaginiamo il Sole fermo al centro del sistema solare e la Terra in rotazione intorno al Sole e su se stessa. Accettando tale ipotesi, le orbite dei pianeti diventano circolari e il loro apparente moto retrogrado si riduce a una conseguenza del moto relativo della Terra e dei pianeti.
Per valutare con serenità il valore e i limiti scientifici del modello copernicano dobbiamo tenere conto del contesto storico in cui tale modello fu prodotto. Ai tempi di Copernico non si distingueva fra verità scientifica (che rappresenta un modello, senza la pretesa di dire l'ultima parola sulla realtá) e verità filosofica o religiosa.
Mettere in crisi il modello geocentrico significava allora scuotere tutto l'edificio della filosofia e della teologia. Non a caso, sia la Chiesa cattolica sia quella luterana, che per tutto il resto erano in conflitto, su una cosa erano d'accordo: mantenere il modello geocentrico e rifiutare quello eliocentrico. I motivi che inducevano le autorità religiose di quel periodo ad assumere una posizione così netta erano tutt’altro che trascurabili. Da una parte, la Terra al centro del mondo sembrava molto più coerente con il racconto biblico del libro della Genesi, che aveva come evento culminante la creazione dell’uomo; dall'altra, il modello eliocentrico, che trasformava la Terra in un pugno di materia vagante nello spazio, sembrava inconciliabile con l’assunto filosofico-religioso della centralità dell'uomo nell'Universo. Queste considerazioni devono essere tenute presenti per valutare la difficoltà di procedere, anche da un punto di vista strettamente scientifico, su un percorso di così grandi implicazioni culturali, filosofiche e teologiche. Oggi il modello eliocentrico ha perso totalmente il suo ruolo di "teoria rivoluzionaria" ed é quindi possibile ricostruire con maggiore obiettività la trama dell'aspetto più propriamente scientifico dell'argomento. Vogliamo però far osservare che anche il modello di Copernico aveva gravi problemi da risolvere. Da una parte, infatti, esso semplificava la struttura del sistema solare; dall'altra però le previsioni basate sui moti circolari dei pianeti risultavano peggiori di quelle allora ottenibili con il modello geocentrico. Così anche Copernico si vide costretto a ricorrere a moti accessori, ad esempio al concetto di epiciclo, cosa che, alla fine, rese il suo modello complicato quanto quello tolemaico.